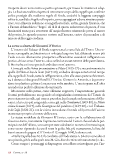Page 318 - Libro Sacro Monte di Varallo
P. 318
ricoperta da un unico tetto a quattro spioventi, qui invece la struttura si sdop- pia. La facciata esorbita rispetto al retrostante corpo della cappella per conferire aulico prestigio alla residenza regale di Erode, cosicché la loggetta campeggia solitaria, candida e fragile nello spazio, senza appoggiarsi ad una struttura poste- riore, vera illusoria soluzione scenograficoteatrale, ardita, geniale finzione, che a Firenze definirebbero “bugia”. Al di là di questa architettura di parata, d’una luminosità senza pari, attraverso all’ampia finestra orizzontale posta al centro del portico, lo sguardo penetra curioso nell’interno, carico di penombra e di mistero della reggia erodiana. La scena scultorea di Giovanni D’Enrico L’interno del Palazzo di Erode rappresenta la vasta Sala del Trono. Una so- lenne scenografia architettonica si sviluppa lungo tre lati, dilatando ancor più l’aula con un illusionismo prospettico efficacissimo essendovi raffigurato un portico, chiuso verso l’esterno, salvo nelle due arcate estreme delle pareti latera- li. Ne risulta così una specie di ambulacro tutt’attorno. Come già nella Prima presentazione a Pilato (1615-17) e successivamente in quella di Pilato si lava le mani (1617-20), ambedue dunque anteriori nel tempo alla cappella di Erode, tutta la raffigurazione, oltre alla stessa parte architettoni- ca, è dovuta ai due grandi fratelli D’Enrico: Giovanni e Antonio, e la penetra- zione tra plastica e pittura è ancora una volta assoluta. L’una trapassa nell’altra creando una perfetta illusione di continuità. Ma mentre nella prima, come abbiamo supposto, l’impostazione generale fu assai probabilmente una geniale ed originalissima invenzione del Tanzio da poco rientrato in valle, qui torna a prevalere la più usuale orchestrazione di Gio- vanni, a lui certo più congeniale, come già nella Condanna (1609-10), in Pilato si lava le mani (1617), nella Guarigione del paralitico (1619-20), e nel Tribuna- le di Caifa (1620-21), con la visione immediata e frontale ed il perno dell’azione mantenuto proprio al centro della scena. Le statue modellate da Giovanni D’Enrico, certo con la collaborazione dì Giacomo Ferro, nonostante l’opinione contraria del Testori che esclude la par- tecipazione dell’allievo, sono sempre state calcolate in numero di trentacinque, come vanno ripetendo da secoli tutte le guide. Ma più esattamente, la lista dei lavori ancora da pagare al D’Enrico il 12 maggio 1640, le elenca così: «Nella Capella dove N. S. fu condotto ad Erode statue n. 34 et un cane alto et uno piccolo, più la sedia quale esso M. Gio. dice che viene stincata statue) n. 4». Come sempre i personaggi si dispongono con effetto coinvolgente per l’im- 318 Cappella - 28